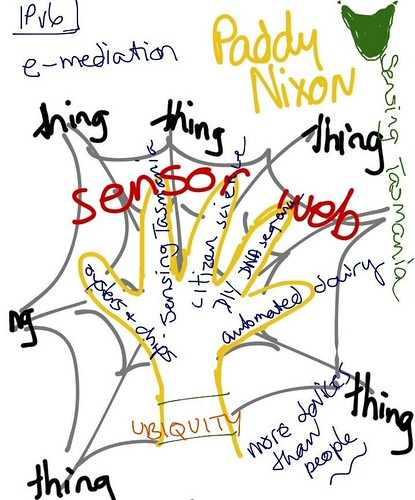Nel mio libro di cinque anni fa sul ruolo e sulle potenzialità del cloud computing in archivi e biblioteche, affrontavo gli impieghi di questo paradigma tecnologico – oggi conosciuto pure dai bambini – non solo nell’ambito di questi due istituti ma, in modo sperimentale (così come, piccolo inciso, sperimentale voleva essere il ricorso al self publishing…), pure nel contesto degli archivi digitali di persona.
In modo molto pratico e concreto, al fine di stabilire se gli spazi di memoria messi a disposizione sulla nuvola possedevano i requisiti previsti dalla teoria per essere riconosciuti o meno come archivi, descrivevo il funzionamento della versione free di tre servizi, vale a dire Memopal, ADrive e Dropbox (Google doveva ancora lanciare il suo Drive, giusto per capire quanto i tempi fossero pionieristici…).
L’e-mail arrivatami qualche giorno fa da ADrive, servizio che nel frattempo ho continuato seppur sporadicamente ad usare, e con la quale mi si avvisa che nell’ottica del continuo miglioramento e potenziamento del servizio la versione Basic a partire dall’1 gennaio 2016 scomparirà (proponendomi nel contempo di abbonarmi alla versione Premium a prezzo vantaggioso), mi ha spinto a controllare come sono messi i summenzionati servizi a distanza di un lustro (nota: per chi volesse rileggersi quanto scritto a suo tempo nel libro, di riferimento è il par. 3.4).
Diciamo innanzitutto, e non è poi una cosa così scontata considerata l’elevata mortalità delle aziende hi-tech, che tutti e tre i servizi sono vivi e vegeti, nel senso che non sono stati chiusi né oggetto di operazioni di merge & acquisition; anzi essi, in linea con il settore, godono di ottima salute ed in particolare Dropbox ne è uno dei leader indiscussi.
Ma veniamo al sodo! Memopal continua ad offrire, nella versione gratuita, 3 GB di spazio di memorizzazione sulla nuvola; pure a scorrere le specifiche di sicurezza non molto è cambiato: utilizzo dei protocolli HTTP / HTTPS ed SSL, RAID 5 e tecnologia MGFS (Memopal Geographical File Systems), scelta in capo all’utente dei file da caricare, possibilità di sincronizzazione multidevice (a prescindere dal sistema operativo), etc. La novità è data dalla posizione di “preminenza” data alle foto; così infatti recita il sito: “nella nostra web app tutte le foto sono organizzate in un album, indipendentemente dalla loro posizione nelle tue cartelle”.
Passiamo ora ad ADrive: come ampiamente ricordato, la versione Basic da 50 GB sta andando in pensione e le farà posto quella Premium da 100 GB (che però possono crescere fino a 20 TB ed oltre); l’interfaccia grafica è stata migliorata e sono state rilasciate app per dispositivi mobili iOS ed Android. Per il resto, oggi come cinque anni fa, si fa leva sulla possibilità di editare sulla nuvola (anche condividendo il lavoro) e di caricare file di grandi dimensioni (il limite è passato da 2 a 16 GB!).
Veniamo infine a Dropbox: lo spazio a disposizione nella versione gratuita di base è tuttora fermo a 2 GB, viene posta particolare enfasi sulle misure di sicurezza adottate (crittografia dei dati archiviati con AES a 256 bit e protezione di quelli in transito con tecnologia SSL/TLS, concepita per creare un tunnel sicuro protetto da crittografia AES a 128 bit o superiore) ma non si specifica la localizzazione dei data center nei quali materialmente finiscono i dati. A proposito di questi ultimi, anzi, si afferma esplicitamente che l’azienda si riserva di spedirli in qualsiasi parte del mondo ma nel rispetto, beninteso, della normativa cd. “Safe Harbour”. Da sottolineare che, diversamente a cinque anni fa, non ho trovato alcun riferimento al fatto che Dropbox si avvalga dei server di Amazon ma alcuni passaggi presenti nella pagina poc’anzi citata mi fanno ritenere che ora Dropbox tenga tutto presso di sé.
Da rimarcare invece come l’azienda californiana, in modo encomiabile, non solo abbia tenuto in vita app per sistemi operativi che contano quote di mercato oramai irrisorie (come Blackberry) ma ne abbia realizzato di ulteriori per Kindle Fire di Amazon (che, come noto monta una versione altamente customizzata di Android) e per il mondo Microsoft (Windows Phone e tablet con Windows). Per finire va sottolineato come pure Dropbox, un po’ come Memopal, abbia tentato di valorizzare le foto salvate al suo interno dai suoi utenti: nello specifico era stata lanciata, con una sorta di spin-off, l’app Carousel, la quale presentava in modo cronologico tutte le foto caricate. Purtroppo l’avventura non deve essere andata esattamente come sperato se, proprio pochi giorni fa, ne è stata annunciata la chiusura per il 31 marzo 2016.
Benché Dropbox si affretti a precisare che le foto non adranno perse ma semplicemente rientreranno all’interno dell’app “originaria”, la quale verrà nel frattempo potenziata con funzionalità ad hoc per le foto, è inutile dire che questa notizia, unita a quella di ADrive, non contribuisca a far sorgere la necessaria fiducia per i servizi di cloud storage. Se dal punto di vista tecnologico questi servizi paiono essere complssivamente affidabili (non si sono infatti sin qui verificate clamorose falle nella sicurezza come capitato in molti settori contigui), le perplessità permangono per ciò che concerne la “cornice legale” e la durata nel tempo del servizio: come si è visto esso è intimamente legato – com’è peraltro normale che sia, trattandosi di aziende private – a logiche di mercato e nel momento in cui la profittabilità viene meno oppure la versione gratuita diviene non più sostenibile (oppure ha semplicemente assolto alla sua funzione “promozionale” per attirare nuovi utenti), semplicemente la si chiude senza tanti giri di parole.
Tutti fattori che, facendo un’analisi costi/benefici, a mio avviso dovrebbero indurre una buona fetta degli utenti ad optare per soluzioni di personal cloud che, benché abbiano un costo, forniscono ben altre garanzie.