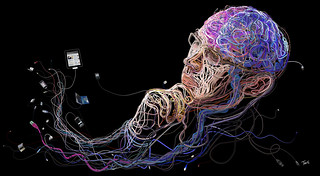Take away: è proprio con questo anglicismo, che letteralmente significa “portar via” ma che oramai tutti noi associamo all’exploit dei cibi da asporto ed ai connessi servizi di food delivery, che le biblioteche di pubblica lettura, duramente colpite dalle restrizioni alla mobilità sociale adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, stanno cercando di rilanciare, perlomeno nella mia regione, il proprio servizio principe, ovvero quello del prestito librario.
Ammetto che dal punto di vista comunicativo lo slogan sia efficace e di sicuro impatto, tale è l’immediatezza del messaggio e chiara la modalità di erogazione del servizio offerto, ma l’idea di assimilare l’operazione di prestito / restituzione di un libro (oggetto con connotazioni valoriali che non sto qui a ricordare) alla consegna a domicilio di una pizza, del sushi o, esempio ancora più calzante, al “ritiro” di hamburger e patatine al McDrive non riesco proprio… a digerirla!
Ma al di là delle scelte comunicative, che possono piacere o non piacere, il punto focale della questione è un altro e decisamente ben più grave. Se il servizio di take away librario può essere interpretato come un tentativo di risposta, ed in questo senso anche come un moto di vitalità, delle biblioteche di pubblica lettura alle prese con questo secondo lockdown, nel contempo ci costringe ad una seria riflessione sulla tenuta complessiva del sistema così come è stato costruito negli ultimi anni.
Fino allo scoppio della pandemia da Coronavirus più o meno tutti vivevamo nella convinzione di aver costruito sistemi bibliotecari sufficientemente strutturati e “ridondanti” (in termini di patrimonio documentario, risorse umane e dotazioni tecnologiche), tali per cui la chiusura di una o più biblioteche del sistema (nodi), non avrebbero sostanzialmente intaccato l’erogazione del servizio ed il suo livello qualitativo.
Pace se l’unico bibliotecario (magari un “precario” dipendente di una cooperativa) si ammalava o andava in ferie, pace se non era stato acquistato o se non era disponibile nella nostra biblioteca di riferimento il libro da noi ricercato, pace se i suoi orari di apertura non erano in linea con le nostre esigenze, pace se… L’appartenenza ad una rete bibliotecaria più ampia, diffusa in modo capillare sul territorio, più “ricca” in termini di personale e di patrimonio documentario, sopperiva alle carenze della singola biblioteca/nodo (esito di anni di pressocchè generale disinteresse da parte degli amministratori, di mancato turnover, di tagli ai fondi…)!
Il Covid ha spazzato via tutte queste certezze: il primo lockdown ha visto un azzeramento dall’oggi al domani dei servizi bibliotecari: chiuse le biblioteche ed a casa i bibliotecari (tanto più in caso di esternalizzazione del servizio), stop a prestiti e restituzioni, stop a qualsiasi attività che prevedesse una qualche forma di interazione fisica (alla faccia della biblioteca come punto di riferimento per la comunità), stop praticamente a tutto!
Da sottolineare che la ripartenza di maggio, lenta e limitata ai servizi basici di restituzione / prestito, è resa possibile grazie a forme di volontariato (spazianti dagli amici della biblioteca, alla Protezione Civile ai giovani del paese) che prodigandosi in encomiabili attività di porta a porta consentono da un lato di recuperare i libri rimasti fuori sin dai giorni del lockdown, dall’altra di consegnare ai cittadini / utenti, bloccati in casa, almeno un bel libro per una buona lettura. Si trattava, va inoltre evidenziato, di una ripartenza a mezzo servizio: di circolazione interbibliotecaria non se ne parla (con le evidenti ripercussioni negative circa la possibilità di accedere a risorse “altre” che vadano al di là del posseduto) e men che meno di riaprire al pubblico gli spazi della biblioteca!
Per questi ultimi bisogna aspettare la bella stagione (benché distanziati, con mascherina, con accessi contingentati, etc.), ma altro non è che un veloce intermezzo. La seconda ondata, scandita dal progressivo accentuarsi delle restrizioni, è infatti dietro all’angolo e manda nuovamente in crisi il sistema bibliotecario, impossibilitato a mettere in campo delle adeguate contromisure.
La questione cruciale a mio avviso è che quelli che erano (sono) i capisaldi irrinunciabili, i punti di forza ed in ultima analisi i valori fondanti delle biblioteche (l’apertura, il ruolo “sociale” a supporto della comunità, la dimensione di servizio, etc.) diventano altrettanti punti di debolezza nel momento in cui i contatti interpersonali devono essere tendenzialmente azzerati. Il ricorso all’accattivante slogan del take away, dunque, rappresenta il comprensibile tentativo di ricordare (agli utenti, agli amministratori pubblici ed in generale a tutte le figure che attorno ad essa ruotano) che la biblioteca c’è e non rinuncia al proprio ruolo, riposizionandosi non a caso su quello che in ultima analisi è il suo compito primario: dare, benché con modalità di contatto “mordi e fuggi”, a ciascuno il suo libro.
PS Nei giorni più duri del primo lockdown a reggere erano quelle biblioteche / quei poli bibliotecari, per fortuna sempre più numerosi, che hanno investito e scommesso nel digitale: l’essere in grado di offrire risorse digitali, l’aver sviluppato per tempo canali di comunicazione ed interazione social ha consentito (benché in favore di un utenza numericamente più ristretta) di continuare la propria operatività. L’accelerazione verso il digitale data dal COVID alla nostra società (dalla didattica a distanza nelle scuole alla maggior confidenza con gli acquisti di beni e servizi digitali – non solo film e musica su piattaforme in streaming, ma anche ebook -, le call, etc.) c’è da scommettere rappresenterà uno dei principali lasciti, obbligando le biblioteche – i cui operatori, che potremmo grossolanamente dividere tra progressisti e conservatori, da anni si accapigliano su queste tematiche – a rompere gli indugi e ripensare e rimodellare sé stesse.