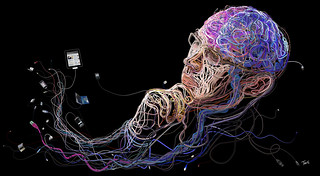
Does the Internet make you smarter? (Illustration for the Wall Street Journal) by Charis Tsevis, on Flickr
In un lunghissimo articolo apparso qualche settimana fa sul The New Yorker a firma di Jill Lepore vengono toccati moltissimi di quei temi da anni al centro del dibattito della comunità archivistica: dall’opportunità di “archiviare Internet” dandogli la necessaria profondità storica al ruolo svolto in questa direzione da organizzazioni non governative come Internet Archive con la sua Wayback Machine (il cui funzionamento però, fa notare l’autrice, ha ben poco di archivistico essendo le varie “istantanee” del web salvate da quest’ultima organizzate semplicemente per URL e per data!) passando per il crescente impegno profuso in questo settore da parte di istituzioni pubbliche (come la British Library o la National Library of Sweden, le quali portano avanti una tradizione tutta europea che affonda le sue radici nell’istituto del deposito legale) per finire con le implicazione derivanti dal fenomeno dei link rot, vale a dire di quei collegamenti ipertestuali non funzionanti che impediscono ai documenti presenti sul web di ricoprire una funzione all’interno del sistema di note e riferimenti analoga a quella ricoperta dai corrispettivi cartacei.
Proprio circa quest’ultimo punto, sul quale peraltro già avevo scritto qualcosa oramai qualche anno fa, vale la pena di sviluppare un paio di ulteriori riflessioni; partiamo dalle parole dell’autrice, la quale a riguardo scrive:
The footnote, a landmark in the history of civilization, took centuries to invent and to spread. It has taken mere years nearly to destroy. A footnote used to say, “Here is how I know this and where I found it”. A footnote that’s a link says, “Here is what I used to know and where I once found it, but chances are it’s not there anymore”
La teoria che soggiace ad una simile impostazione è quella, oramai classica, di Elisabeth Eisenstein e della “stabilità tipografica”: secondo questa autrice l’invenzione della stampa a caratteri mobili non fu un fatto meramente tecnologico ma ebbe profonde ricadute industriali e sociali al punto da segnare lo sviluppo successivo dell’Occidente, contribuendo ad assicurarne nel lungo periodo il predominio globale; in particolare la stampa in tirature sempre più elevate unitamente alla “standardizzazione” dell’oggetto libro, con l’affermazione di aree ben definite ed individuabili (frontespizio, colophon e soprattutto apparato critico / notazionale), da una parte rese possibile una migliore e più efficace circolazione delle idee (non più soggette a quelle storpiature imputabili ad errori più o meno involontari da parte del copista) dall’altra, grazie alla possibilità data dalla presenza di precisi riferimenti bibliografici e documentali di verificare ed eventualmente confutare o correggere le diverse tesi dibattute, pose le basi per lo sviluppo della scienza e della cultura occidentali.
Come ricorda Jill Lepore nel passaggio poc’anzi citato, tale secolare sistema è stato brutalmente messo in crisi all’avvento del digitale: com’è stato possibile ciò? quali le cause?
Personalmente ritengo che additare come colpevoli i soli link rot sia semplicistico; questi ultimi sono a mio modo di vedere parte di un problema ben più complesso che anzi li trascende: è la società contemporanea nel suo complesso, bulimica di informazioni sempre aggiornate, che ci porta a “bruciarle” dopo pochi minuti, che ci spinge ad avere prodotti editoriali digitali redatti in più versioni nel tempo (versioning) e capaci di aggiornarsi spesso e volentieri senza che venga mantenuta traccia della versione precedente (il che, piccolo inciso, porta al tramonto del concetto di edizione), che richiede che gli innumerevoli articoli e post pubblicati vengano tumultuosamente “updated” ed altrettanto repentinamente spostati oppure messi offline una volta che perdono di attualità, senza che vi sia il tempo necessario per una stratificazione delle idee.
In questo senso Internet ed il Web costituiscono, nell’accezione massmediatica e filologica del termine, il palinsesto perfetto: tutto è spostabile, tutto è cancellabile, tutto è (digitalmente) “sovrascrivibile”. Questo richiamo alla prassi medievale di raschiare e cancellare i codici, pergamenacei e non, rappresenta peraltro simbolicamente il tramonto dell’epoca di “stabilità” delineata dalla Eisenstein ed il ritorno, per contro, ad una che, parafrasando, possiamo definire di “instabilità tipografica”. Dando ciò per assodato, la domanda da porsi è a questo punto la seguente: i rischi paventati da Jill Lepore sono concreti?
La risposta, con tutta evidenza, non può che essere affermativa: come già ricordato è il metodo scientifico stesso che prevede, tra gli altri, il requisito della verificabilità e quest’ultima non può prescindere, a sua volta, dalla presenza di una fitta rete di rimandi e riferimenti. Venendo questi meno, la ricerca non può dirsi tale anche se ciò non significa automaticamente che non vi saranno alcuni benefici. Ad esempio lo “sganciamento” da auctoritas citate più o meno acriticamente potrebbe portare a percorrere nuove vie; parallelamente la mole crescente di dati prodotti (big data), per di più spesso e volentieri disponibili liberamente ed in formati aperti (open data), pertanto con la possibilità di trattarli ed incrociarli / collegarli (LOD) per mezzo di elaboratori, apre il campo a nuove frontiere nelle ricerche (in ambito storico perché non pensare, ad esempio, ad una nuova storia quantitativa?).
In definitiva quel che avremo non sarà altro che, com’è forse giusto che sia, una ricerca rispecchiante la società (digitale) che l’ha prodotta; in quest’ottica è doveroso che le istituzioni deputate alla conservazione, archivi e biblioteche, aumentino i propri sforzi.
Sicuramente un primo ambito d’intervento dev’essere, sulla falsariga di quanto fatto da Internet Archive e da molte biblioteche centrali, quello teso a dare profondità storica ad Internet “archiviandolo” ma anche contribuendo alla diffusione di persistent URL. Ma un secondo, ed in prospettiva persino più importante, terreno d’azione sarà inevitabilmente quello della gestione e conservazione dei big data, fenomeno che a mio avviso caratterizzerà gli anni a venire: è pertanto impensabile che gli archivi e le biblioteche non giochino un ruolo cruciale nel “mantenimento” tout-court dei vari dataset che, più dei singoli documenti, saranno alla base delle ricerche dei prossimi anni e dai quali dipenderà, c’è da scommettere, il progresso scientifico dei prossimi decenni.


